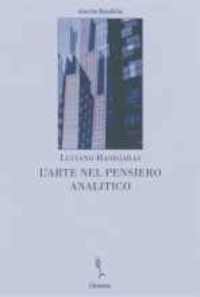
Questo libro nasce come proposta di chiarire l'incidenza del problema dell'arte nella filosofia analitica. In esso si indicano alcuni passaggi teorici centrali che ci consentono di cogliere elementi di apertura impliciti già nel primo porsi di quel problema e che oggi possono indurci a guardare con occhi diversi l'intero complesso dei rapporti tra filosofia analitica e filosofia continentale. Dopo aver ricordato la "svolta linguistica" di Frege e quel particolare aspetto della sua teoria del senso e del significato - la radicalità della cesura tra scienza e poesia, poi ereditata dall'empirismo logico -, il libro mostra un'altra strada: la concezione del significato in I. A. Richards ed il suo practical criticism di derivazione romantica, la concezione dell'opera d'arte come espressione della forma del sentimento in S. Langer, i linguaggi dell'arte in N. Goodman, infine il problema del "riconoscimento" delle altre menti in S. Cavell. Sulla traccia di questa problematizzazione del rapporto tra conoscenza ed arte, vengono discusse le tesi di M. Black, A. Danto, R. Wollheim, E. Gombrich, I. Calvino, D. Davidson. Il libro ha il carattere del "saggio", dell'esplorazione. La ricerca fa emergere una linea di pensiero che arriva sino a noi, poiché chiarisce i modi in cui noi qui ed ora parliamo di arte e di conoscenza, e come siamo arrivati a parlarne in questi modi, e quanto valga forse ancora mantenere o criticare o sviluppare alcuni di questi modi. C'è una convinzione a monte: che la filosofia, per continuare, deve saper guardare al suo interno, affrontando le sue diverse anime; e deve saper guardare al suo esterno, affrontando le diverse voci della cultura entro cui essa opera e a cui si rivolge.
Sommario
introduzione
1. linguaggio, scienza e poesia in g. frege. il “senso” (ma non il valore di verità) della poesia
1. Il problema del senso in aritmetica, nel linguaggio scientifico e nel linguaggio poetico
2. I pensieri e i sensi che non sono pensieri
3. Un linguaggio formalizzato per la scienza
4. La riduzione della prospettiva fregeana effettuata da Russell
2. funzioni linguistiche e critica letteraria in i. a. richards. la poesia come “esperienza poetica” e “strumento di ricerca”
1. Nella Cambridge “umanista”
2. La funzione simbolica e la funzione evocativa del linguaggio
3. Il significato della bellezza
4. La critica letteraria, l’insegnamento alla lettura, l’influenza di T. S. Eliot
5. Verità poetica e immaginazione nella Biographia Literaria di Coleridge
6. Dalla “interanimazione” delle parole alla natura transattiva della metafora
3. sul valore conoscitivo delle arti. la metafora (m. black e d. david-son), il sentimento (s. langer), l’interpretazione (a. c. danto)
1. L’analisi e la conferma di Black della tesi di una “creatività” cognitiva della metafora
2. La difesa del “letterale” in Davidson. La metafora come “lavoro onirico” del linguaggio
3. Conoscenza ed espressione nelle arti in Susanne Langer. L’opera d’arte come “forma espressiva” del sentimento
4. Il simbolo artistico come espressione della “logica della coscienza”
5. La “trasfigurazione” dell’oggetto comune in opera d’arte in Danto. Il concetto nell’interpretazione
6. L’opera, la mente ed i due livelli (superficiale e profondo) dell’in-terpretazione
4. un nuovo rapporto tra mondi della conoscenza e mondi delle arti. la prospettiva costruzionista di n. goodman
1. Verso una epistemologia “riconcepita” nei suoi concetti fondanti
2. Conoscenza e forma dichiarativa del linguaggio conoscitivo
3. Conoscenza e concezione corrispondentistica della verità
4. Conoscenza, riferimento e universi di discorso
5. Dalle entità immaginarie alle descrizioni e raffigurazioni di mondi
6. Forma, contenuto e problema ontologico. La relatività del realismo
7. Costruzione di mondi e questione della loro “giustezza”
5. identità e interpretazione dell’opera d’arte. n. goodman a confronto con r. wollheim, e. gombrich, i. calvino
1. Verso una riunione in filosofia. Il progetto di ricerca sui sistemi simbolici delle arti
2. Sulle proprietà possedute ed espresse da un’opera d’arte
3. La questione del falso in pittura e della storia di produzione dell’opera. Il significato pittorico (ed artistico in genere) in Wollheim
4. Il significato delle immagini. Un rimando a Gombrich e alla storia dell’arte
5. Identità “iscrizionale” (ed infalsificabilità) del testo o ruolo costitutivo del lettore? Il “problema di Borges” e i livelli di realtà nell’opera letteraria in Calvino
6. L’opera letteraria tra testo ed interpretazione
6. mente, letteratura e “critica filosofica” in s. cavell
A. L’apertura reciproca oggi di filosofia e letteratura e la sfida dello scetticismo
1. Un nuovo emblema per la filosofia: “il castello dei destini incrociati”
2. La continuazione del pensiero moderno e la questione di una inadeguata comprensione delle sue divisioni
3. Dalla competizione reciproca di filosofia e letteratura alle due direzioni dello scetticismo: il dubbio sul mondo e il dubbio sulle altre menti
4. Un esempio della critica letteraria / filosofica di Cavell: il problema del riconoscimento dell’ “altro” in letteratura
B. La mente, l’automa, la minaccia del dubbio, la ricerca dell’ordinario in Der Sandmann di E. T. A. Hoffmann
1. Il fantastico nella /della filosofia? Una nota sulla interpretazione reciproca di realtà e fantasia
2. Il racconto fantastico di Hoffmann e l’analisi di Freud del “perturbante”
3. Gli occhi limpidi di Clara e lo sguardo obliquo di Nathanael. Il carattere fenomenicamente catastrofico della visione perturbante in S. Weber
4. L’interpretazione di Cavell e la straordinarietà dell’ordinario. Il dubbio sulle altre menti e il rapporto tra animato ed inanimato
5. La visione terrorizzante dell’ordinario e la follia nel riconoscimento mancato
riferimenti bibliografici
indice dei nomi